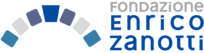“Uno è il castigo del carnefice che, negando l’umanità della sua vittima nega la sua stessa umanità; in questo modo diventa carnefice di sè stesso”. A partire da questa citazione di Vasilij Grossman è possibile comprendere quali sono stati i temi principali intorno ai quali si è articolata la discussione dell’incontro “Crocevia della storia del Novecento”, proposto dalla Fondazione Zanotti questo venerdì 21 novembre: come rendere realmente giustizia alle vittime di un massacro, qual è stato e qual è ancora oggi il ruolo delle ideologie e come funziona la memoria storica.
L’evento ha avuto come centro la presentazione del libro “Sangue della resistenza. Storia dell’eccidio di Porzus” di Tommaso Piffer, il quale, ospite all’incontro, con un accurato lavoro di archivio incrociando documenti inediti italiani e sloveni, ha voluto far luce su una delle vicende più controverse della storia della resistenza italiana, e che è stata molto fraintesa dagli studi fatti a posteriori: l’eccidio di Porzus. L’autore, ricostruendo i fatti storici della carneficina, e mettendo in risalto la voce non solo dei grandi protagonisti della vicenda ma anche delle altre figure che spesso passano in secondo piano, ha cercato non solo di dare un resoconto storico, ma di indagare questi temi ricostruendo un percorso che riuscisse a far emergere il risvolto umano della vicenda: cercando di far capire che dietro le azioni militari ci sono uomini che sono morti per un ideale maggiore e che ogni vita è degna di essere raccontata e presa in considerazione.

È sempre stato infatti complesso riuscire a identificare i responsabili della carneficina del 7 febbraio 1945, che ha visto la morte dei partigiani dell’Osoppo, ad opera di un commando di partigiani comunisti dei GAP, attraverso un vero e proprio scontro interno partigiano. Al centro dello scontro sul fronte italo-sloveno c’era la volontà da parte del partito comunista di ammettere i territori del Friuli-Venezia Giulia alla Jugoslavia, per due motivazioni: una nazionale, con l’obiettivo di riunire tutti gli sloveni in un unico popolo, e uno politico, per favorire l’espansione del partito socialista guidato da Tito. Sono stati molti gli interrogativi su chi avesse ordinato ai GAP di compiere questo massacro contro l’altro gruppo di partigiani osovani: per alcuni è stato il Partito comunista italiano, per altri il comando della divisione Garibaldi-Natisone, per altri ancora il IX Corpo sloveno. Piffer, nel suo libro, cerca di rispondere a questo quesito smascherando i reali carnefici della strage e mettendo in luce come l’eccidio di Porzus non rappresenti unicamente un’operazione di guerra di frontiera ma un vero e proprio centro gravitazionale delle tre grandi fratture del Novecento europeo.
La prima di queste fratture di cui l’eccidio si fa portavoce è, infatti, quella tra fascismo e antifascismo: le tre divisioni di partigiani, quella slovena, garibaldina e osovana erano unite contro un unico nemico che era quello fascista. La seconda è quella nazionale tra italiani e sloveni per il controllo dello stesso territorio. E infine, l’ultima, quella ideologica, tra forza comuniste e anticomuniste, che è stata fondamentalmente la matrice generativa della strage. Durante l’incontro, Piffer, dopo aver raccontato la morte tragica di uno dei partigiani osovani, si è interrogato su cosa significhi realmente rendere giustizia alle vittime di una strage storica, e su quali siano i limiti del lavoro dello storico: “Cosa può rendere davvero giustizia? Questa è una domanda che lo storico non può non farsi. Si rende conto che niente può rendere giustizia di questa vita, nemmeno raccontare la vicenda.”.

Poi aggiunge che, se osserviamo con distacco e da una certa distanza la vicenda di Porzus, notiamo come possa emergere una pietà per le vittime e al tempo stesso una pietà per i carnefici: “anche il carnefice, ha distrutto la sua vita, oltre a quella dei suoi nemici.”.
Mettere in evidenza anche il triste destino di infelicità eterna dei carnefici, non deve essere letto in chiave giustificatoria del loro operato, ma come una possibilità per comprendere meglio la forza motrice delle ideologie: chi uccide, infatti, lo fa in nome di una ideologia, in una logica in cui il nemico non viene più considerato in quanto umano, ma in quanto personificazione di una ideologia. È importante sottolineare questo aspetto, perché, come afferma Piffer, oggi è complesso e arduo posizionarsi all’interno di questa mentalità, in cui il modo di approcciarsi alla vita e alla morte dipendeva da logiche differenti. La memoria storica, agendo come cornice della narrazione delle vicende, ci permette di indagare ancora oggi queste realtà se pur con limitate possibilità.
Piffer, infatti, nell’incontro ha voluto concludere riassumendo come alcune cose siano ormai mature da essere consegnate alla storia, e che debba esserci una componente di memoria ed oblio che devono marciare insieme. È giusto ricordare le vittime della strage e di ogni storia dolorosa, ma è altrettanto necessario proseguire in nome di valori che tengano conto anche della componente umana, ricordando l’insegnamento che ci viene trasmesso.